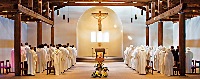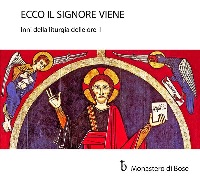Multithumb found errors on this page:
There was a problem loading image 'images/stories/Qiqajon/recensioni/thumbnails/thumb_ildigiunocristiano.png'
There was a problem loading image 'images/stories/Qiqajon/recensioni/thumbnails/thumb_ildigiunocristiano.png'
Testimoni, 5/2009
di SERGIO ROTASPERTI
Nascostamente nel quotidiano rischiamo di vivere i nostri rapporti
fondandoli sul bisogno o interesse. La pratica del digiuno vuole farci
passare da "predatori" a servitori degli altri
Continua la lettura
Multithumb found errors on this page:
There was a problem loading image 'images/stories/Qiqajon/recensioni/thumbnails/thumb_intuttelecoselaparola.png'
There was a problem loading image 'images/stories/Qiqajon/recensioni/thumbnails/thumb_intuttelecoselaparola.png'
Il Sole 24 ORE, 15 marzo 2009
di GIANFRANCO RAVASI
Una felicissima antologia che una monaca della comunità piemontese di
Bose, Lisa Cremaschi, in collaborazione con Biancamaria Mariano, ha
allestito attingendo all'imponente mole degli scritti massimiani
Continua la lettura
Il giornale della musica CLASSICA 03|09
di PAOLO DA COL
La comunità di Bose trova invece un suo personale e convincente
percorso, che si svolge ancora tra impulso innovativo e solco della
tradizione
Continua la lettura