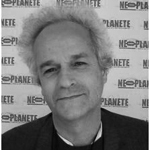LOUIS-MARIE CHAUVET
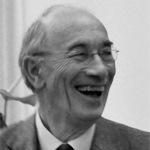 Nato in Vandea nel 1942, prete dal 1966, nel suo ministero si è dedicato tanto all’insegnamento (è stato docente di teologia sacramentaria all’Institut catholique di Parigi dal 1972 al 2007), quanto alle attività pastorali diocesane (attualmente è parroco nella diocesi di Pontoise). È stato a lungo membro del consiglio di direzione della rivista internazionale di teologia Concilium.
Nato in Vandea nel 1942, prete dal 1966, nel suo ministero si è dedicato tanto all’insegnamento (è stato docente di teologia sacramentaria all’Institut catholique di Parigi dal 1972 al 2007), quanto alle attività pastorali diocesane (attualmente è parroco nella diocesi di Pontoise). È stato a lungo membro del consiglio di direzione della rivista internazionale di teologia Concilium.
Consigli di lettura:
- Du symbolique au symbole. Essai sur les sacrements, Paris 1979. Trad. it.: Linguaggio e simbolo. Saggio sui sacramenti, ElleDiCi, Leumann 1982.
- Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, Paris 1986. Trad. it. : Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza cristiana, ElleDiCi, Leumann 1990.
- Les sacrements. Parole de Dieu au risque du corps, Paris 1993. Trad. it., I sacramenti. Aspetti teologici e pastorali, Àncora, Milano 1997.
- Le corps, chemin de Dieu: les sacrements, Paris 2010
- Della mediazione. Quattro studi di teologia sacramentaria fondamentale, Cittadella, Assisi 2006.
- L'umanità dei sacramenti, Qiqajon, Magnano 2010.